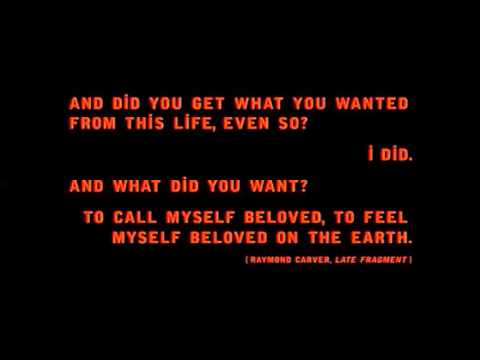Sono ancora così abituato alla mia ultima moto (quella che si rompeva ogni secondo giorno) che non riesco a fidarmi di questa. Ogni volta che sento puzza di plastica penso subito che stia partendo qualcosa, ma mi rassicuro quando realizzo che è solo la spazzatura che viene bruciata sul ciglio della strada.
Ho passato un’intera settimana in Unawatuna e avrei potuto spenderne tranquillamente un’altra ancora, ma ho mete ambiziose (e lontane) prima di chiudere il mio cerchio a Negombo.
La spiaggia di Unawatuna è ampia, sabbiosa, piena di bar e ristoranti. E l’ideale per famiglie e bambini, ma anche piuttosto monotona. Ci passo un paio di giorni perché è vicina alla guesthouse, ma soprattutto alla mia bettola di Roti preferita. Quakche metro più avanti c’è un bar piuttosto hipster, ma ancora accessibile, dove posso buttarmi sui cuscini e ingollare succo di papaia e ananas come se fossi sdraiato a letto. I classici di Bob Marley sono la colonna sonora del locale.
Stanco di oziare, salto in moto e raggiungo Jungle Beach, un paio di calette a ridosso di colline fitte di vegetazione. Anche qui il corallo è quasi inesistente, ma in compenso ci sono un sacco di granchi colorati, pesci Picasso, pesci angelo, pesci unicorno e pesci chirurgo in pigiama.
Durante la settimana la spiaggia appartiene ai turisti, ma il weekend è popolata dai cingalesi. Diventa davvero affollata e l’atmosfera è più festosa. Adulti e bambini si divertono un mondo: si rincorrono, si lanciano la sabbia, si trascinano in acqua per le gambe, fanno la lotta.
Ogni tanto, qualche scimmia scende dagli alberi vicino al ristorante e i cani della spiaggia gli fanno la posta da sotto. Le scimmie scattano all’indietro, ma poi si fanno coraggiose e afferrano i biscotti dalle mani dei turisti che glieli offrono.

«Oddio, quante scimmie, vieni!» Grido ad un’altra backpacker che ho conosciuto da un paio di giorni.
«Come sei tenero…» Replica lei. «Tra un paio di settimane non ne potrai più delle scimmie!»
Sarà, adesso però gli scatto decine di fotografie.
Lascio Unawatuna un paio di notti dopo, diretto ad Ahangama. La tipa mi ha suggerito un posto molto carino dove però non resisto che una notte. Il dormitorio costa sedici dollari, una cifra indecente. I prezzi del cibo e delle bevande sono così alti che non riesco a non sentirmi sfruttato. L’unica cosa positiva è scoprire, tramite il proprietario del posto, che domani sera ci sarà una parata, a Pilana, per celebrare la Luna piena. A quanto pare, questa festa (chiamata Prahara) è la più importante di tutto l’anno.
Il mattino successivo rimetto tutto nello zaino e torno a Unawatuna. Trovo un ostello a ridosso di una collina, nascosto nella vegetazione e a venti minuti a piedi dal mare. Qui non c’è l’aria condizionata e le camere sono piuttosto spartane, ma mi bastano dieci minuti per sentirmi a casa.
Il proprietario, Cartoon, è un tranquillone. Lui e il suo amico Wastu, gestiscono l’ostello da circa tre anni e l’hanno sistemato insieme a degli ospiti con murales e decorazioni di tutti i tipi.
Due cani di piccola-media taglia, Coco e Lio, mi accolgono leccandomi le braccia. Coco si sdraia pancia all’aria e mugola che lo coccoli. Cagna.

Insieme ad un’altra ospite dell’ostello, visito il tempio di Yatagala Raja Maha Viharaya. Le celebrazioni della Luna piena coinvolgono tutta la comunità, che prega, accende candele ed omaggia i propri idoli con fiori e canti. Il tempio è ricavato da una nicchia sotto un’enorme roccia. Le luci al neon illuminano le statue in stucco con la loro luce fredda, ma non incidono sull’atmosfera. Mi piacerebbe fotografare tutto questo, ma non mi va di puntare l’obiettivo in faccia a questa gente. Scatto un paio di fotografie in sordina, torniamo alla moto e puntiamo verso Pilana.

Bancarelle di cibo, dolciumi e vestiti sono circondati da una folla schiacciata dal traffico. Il villaggio è sviluppato attorno ad un’unica strada. In lontananza vedo una specie di parco giorno illuminato a giorno da LED multicolori e la mia amica mi dice che quella è in realtà la pagoda!
Stanchi della folla, cominciamo a domandare in giro circa la parata vera e propria. Un tizio ci dice di proseguire per un chilometro.
«Prendiamo la moto?» Chiede la tipa.
«Un chilometro sono dieci minuti a piedi, andiamo…»
Dopo venti minuti chiediamo di nuovo e otteniamo la stessa informazione.
«Un chilometro.»
«Si ma quanto ci vuole a piedi?!»
«Mezz’ora»
Mi volto verso la tipa. «Saranno almeno cinque chilometri, torniamo indietro.»
Ci immergiamo di nuovo nella folla, recupero la moto e rifacciamo tutta la strada in sella. Quando la polizia ci intima di fermarci capiamo di essere arrivati.

La parata è composta da gruppi di acrobati, maschere, ballerini e giocolieri. Alcuni ragazzini fanno salti mortali e atterrano a piedi nudi sull’asfalto. Il pezzo sono gli elefanti colorati a LED. Queste povere bestie sono costrette a sfilare appesantite da file di catene al collo e catenacci ai piedi. Gli elefanti ondeggiano a destra e sinistra appena dietro a di percussionisti e sembra proprio che danzino.
«Si muovono così quando sono confusi.» Mi spiega la tipa.
In effetti non sembrano passarsela troppo bene, mi fanno davvero pena. Ad ogni modo, la parata si esaurisce e prosegue verso il centro; noi ne approfittiamo per tornare all’ostello.

Il sabato mattina Cartoon ci propone riso con curry ed una festa sulla spiaggia. Compriamo da bere ed in serata siamo tutti attorno al tavolo in giardino a brindare, ascoltare musica e giocare a carte. Una ragazza entra nell’ostello per usare il bagno. Quando torna, indica l’ostello col pollice e dice, con grande tranquillità, che c’è un incendio. Ci voltiamo tutti quanti a guardare ed una nuvola di fumo nero avvolge il salone. Saltiamo dalle panche e riempiano ogni contenitore possibile di acqua. In una stanzetta, le gabbie dei cani, in plastica, bruciano esalando diossina e le pareti sono già nere di pece. Spegniamo l’incendio in poco tempo e trasciniamo la roba rimasta più o meno integra in giardino. Dopo un’oretta, come se nulla fosse accaduto, andiamo alla festa in spiaggia. Stasera è il compleanno di Wastu e lui vuole assolutamente festeggiare. Non parla bene inglese, ma in compenso regala sorrisi a tutti quanti.
Torniamo alle cinque del mattino completamente sbronzi e assonnati. L’ostello resta in silenzio fino all’ora di punta, quando la calura ci costringe ad uscire dalle stanze.
Passa un altro giorno. Stavolta vado alla spiaggia di Dalawella, una specie di piscina naturale protetta da degli scogli affioranti. Un cartello vieta di toccare le tartarughe marine, al che guardo verso il mare e vedo un buon numero di persone con le maschere da snorkeling concentrate in un paio di punti. Ne noleggio una anch’io (per trecento rupie) e mi immergo per controllare. Ci sono due tartarughe enormi, una forse un metro e mezzo, che nuotano tranquille alla ricerca di alghe.
Tutte queste cose che scrivo sono solo un decimo di quello che ho fatto a Unawatuna, ma ero troppo impegnato a godermela per fermarmi a scrivere. Ad ogni modo, è arrivato il momento di caricare lo zaino sulla moto. A malincuore, saluto la piccola famiglia dell’ostello (incluso il gruppetto che sta ritinteggiando la stanza che ha preso fuoco) e punto verso Hiriketiya.
Sono già piuttosto in ritardo. Dovevo partire entro le quattro per arrivare a destinazione prima di sera, ma l’odore di gamberetti grigliati che proviene da un ristorante sula spiaggia è troppo invitante e DEVO fermarmi. Sono in ritardo comunque. Il sole lascia la scena alle luci artificiali e realizzo di avere una guida piuttosto rischiosa davanti a me. Quando anche il cameriere cingalese si premura di dirmi di andare piano capisco di essere piuttosto nella m.
Pedoni e biciclette sono sagome nere stagliate contro i fanali di mezzi in transito. Attraversano la trada furtive, a volte dubbiose, altre troppo sicure di sé. Otre a loro, a tenermi vigile ci pensano i tuk-tuk che si immettono in corsia senza aspettare di avere la strada sgombra o, peggio, che fanno inversione i marcia all’improvviso. A metà percorso, mi fermo vicino ad una coppia di turisti sulla sessantina, inglesi, dove posso trovare uno sportello del bancomat. Loro mi chiedono dove sto andando e io non riesco a ricorda il nome della mia destinazione.
«mhh, ancora un’ora di strada.»
«oh, bloody hell!» replicano loro all’unisono nell’espressione più inglese di tutte.